|
Itinerari
Culturali nella Provincia di Asti
Alla
scoperta
di
Monastero Bormida,
patria
di Augusto Monti.
"In
val di Bormida i paesi, i principali, sono posti quasi tutti sopra il fiume,
presso al punto dove nella valle maestra sboccano uno o più valloni
laterali, valli di torrentacci, magri di acque e precipitosi di corso,
Tatorba, Uzzone e simili. Fontane, fossi, rivi, torrenti, tutta l'acqua
di quell'imbuto, o poca o molta, per le pendici si convoglia là,
a quel centro a quella confluenza: e là pure vanno a cascare naturalmente
persone alla messa od al comune, carri e derrate al mercato, novelle, racconti.
E quando il tempo è buono, manco male, tutta  quell'acqua
- sorgive, acquitrini, ruscelli, fili d'argento tra i sassi e il verde
- lemme lemme se ne cola laggiù, rinfresca, irriga, abbevera, fa
muovere le ruote dei mulini, ed è una bellezza, ed è una
benedizione. Ma quando al padreterno lassù gli gira la testa e su
quel cielo da tutte le parti nuvole richiama, nuvole brutte verdi e pregne
di minacce, e poi, d'una saettata in mezzo a quell'apocalisse, schianta
squarcia via tutto, e dallo sdruscio acqua grandine manda, giù a
scatarosci: allora fontane rigurgitano, fossi corrono colmi, rivi traboccano,
torrenti rapiscono ruinano, e tutta quell'iradiddio purtroppo va a finire
laggiù. E ne san qualcosa tutti quei borghi posti su quel fiume:
e qualcosa ne sa Cortemilia, specie Borgo San Michele, la covata di case
in riva al Bormida. Anzi Cortemilia allora, adesso forte non più,
aveva perciò una specialità, oltre a quella delle robiole:
un ponte il quale era costruito in modo così ingegnoso che sempre,
alla piena, tavole travi tronchi sterpi fasciname rapiti dall'onda s'impigliavano
tra quelle pile e lì, si capisce, facevan presto a fare diga; ma
il ponte di Cortemilia, come si sapeva, era debole delle ginocchia davanti
e per un po', come poteva, reggeva, reggeva, ma poi, di schianto, ad ogni
piena, puntualmente, si lasciava andare, e lì si sapeva quel che
succedeva: le vie basse di Cortemilia, è vero, si svuotavano in
un attimo, ma in compenso l'alluvione si rovesciava sui paesi di sotto,
Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero, ecc., dove allora, allez,
venisse un accidente a Cortemilia e al suo ponte, per quei Noè di
sotto era peggio del diluvio universale" Così scriveva Augusto Monti,
ne "I Sansossi'" a proposito dell'inondazione del 1948. quell'acqua
- sorgive, acquitrini, ruscelli, fili d'argento tra i sassi e il verde
- lemme lemme se ne cola laggiù, rinfresca, irriga, abbevera, fa
muovere le ruote dei mulini, ed è una bellezza, ed è una
benedizione. Ma quando al padreterno lassù gli gira la testa e su
quel cielo da tutte le parti nuvole richiama, nuvole brutte verdi e pregne
di minacce, e poi, d'una saettata in mezzo a quell'apocalisse, schianta
squarcia via tutto, e dallo sdruscio acqua grandine manda, giù a
scatarosci: allora fontane rigurgitano, fossi corrono colmi, rivi traboccano,
torrenti rapiscono ruinano, e tutta quell'iradiddio purtroppo va a finire
laggiù. E ne san qualcosa tutti quei borghi posti su quel fiume:
e qualcosa ne sa Cortemilia, specie Borgo San Michele, la covata di case
in riva al Bormida. Anzi Cortemilia allora, adesso forte non più,
aveva perciò una specialità, oltre a quella delle robiole:
un ponte il quale era costruito in modo così ingegnoso che sempre,
alla piena, tavole travi tronchi sterpi fasciname rapiti dall'onda s'impigliavano
tra quelle pile e lì, si capisce, facevan presto a fare diga; ma
il ponte di Cortemilia, come si sapeva, era debole delle ginocchia davanti
e per un po', come poteva, reggeva, reggeva, ma poi, di schianto, ad ogni
piena, puntualmente, si lasciava andare, e lì si sapeva quel che
succedeva: le vie basse di Cortemilia, è vero, si svuotavano in
un attimo, ma in compenso l'alluvione si rovesciava sui paesi di sotto,
Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero, ecc., dove allora, allez,
venisse un accidente a Cortemilia e al suo ponte, per quei Noè di
sotto era peggio del diluvio universale" Così scriveva Augusto Monti,
ne "I Sansossi'" a proposito dell'inondazione del 1948. Così, senza che una virgola possa essere cambiata, regge il testo
montiano a drammatica didascalia della disastrosa alluvione del novembre
1994. E, a farne le spese più pesanti, in tutti i luoghi dal Monti
sopra citati, è stato proprio il ponte romanico di Monastero Bormida,
l'elegantissima struttura la cui architettura è stata stravolta
dalla piena del "torrentaccio": divelte le spallette, lesionate le maestose
arcate, sradicata la cappella votiva simbolo di una fede popolare tanto
ingenua quanto sentita. Era l'emblema, quel ponte, non solo del paese ma
di un intero territorio, pertanto si può essere certi che la gente
di Monastero, con l'ostinazione caparbia propria di questi luoghi, si opererà
perchè ritorni ad esserlo in tutta la sua bellezza originaria, aiutata
in quest'opera di non piccolo conto da istituzioni, enti e sodalizi che
al simbolo privilegiato di Monastero, sono da sempre affezionati. Ponte
romanico e torrente Bormida: un rapporto di odio e amore complesso perchè,
se è vero che il paese è conosciuto grazie alla splendida
architettura monumentale del concentrico - campanile, castello, chiesa,
piazza e vicoli - di cui il ponte è straordinaria anticipazione,
è altrettanto vero che sul torrente che gli dà il nome, da
un secolo a questa parte, non si può dire che male. E' infatti la
sua acqua avvelenata dalle scorie di aziende chimiche che stanno a monte,
e per questo motivo scorre rossastra in mezzo a quei ghiaioni dove un tempo,
raccontano i più anziani fra gli abitanti, nidificavano gli aironi.
Augusto Monti, in apertura del volume sopra citato, inserisce il nome del
suo paese natale al primo rigo della prima pagina: un tributo d'affetto
che il futuro professore del D'Azeglio di Torino ripeterà in diverse
occasioni, accumunando il nome di Monastero Bormida - da lui definito "una
terricciuola tra Langhe e Basso Monferrato" - ad altre località
contigue non solo per geografia fisica ma per geografia d'affetto: Ponti,
Monesiglio, Canelli, Acqui, Bistagno... Ma qui, riproponendo in occasione
del trentennio della morte di Augusto Monti un itinerario prettamente astigiano
alla scoperta dei suoi luoghi,
Così, senza che una virgola possa essere cambiata, regge il testo
montiano a drammatica didascalia della disastrosa alluvione del novembre
1994. E, a farne le spese più pesanti, in tutti i luoghi dal Monti
sopra citati, è stato proprio il ponte romanico di Monastero Bormida,
l'elegantissima struttura la cui architettura è stata stravolta
dalla piena del "torrentaccio": divelte le spallette, lesionate le maestose
arcate, sradicata la cappella votiva simbolo di una fede popolare tanto
ingenua quanto sentita. Era l'emblema, quel ponte, non solo del paese ma
di un intero territorio, pertanto si può essere certi che la gente
di Monastero, con l'ostinazione caparbia propria di questi luoghi, si opererà
perchè ritorni ad esserlo in tutta la sua bellezza originaria, aiutata
in quest'opera di non piccolo conto da istituzioni, enti e sodalizi che
al simbolo privilegiato di Monastero, sono da sempre affezionati. Ponte
romanico e torrente Bormida: un rapporto di odio e amore complesso perchè,
se è vero che il paese è conosciuto grazie alla splendida
architettura monumentale del concentrico - campanile, castello, chiesa,
piazza e vicoli - di cui il ponte è straordinaria anticipazione,
è altrettanto vero che sul torrente che gli dà il nome, da
un secolo a questa parte, non si può dire che male. E' infatti la
sua acqua avvelenata dalle scorie di aziende chimiche che stanno a monte,
e per questo motivo scorre rossastra in mezzo a quei ghiaioni dove un tempo,
raccontano i più anziani fra gli abitanti, nidificavano gli aironi.
Augusto Monti, in apertura del volume sopra citato, inserisce il nome del
suo paese natale al primo rigo della prima pagina: un tributo d'affetto
che il futuro professore del D'Azeglio di Torino ripeterà in diverse
occasioni, accumunando il nome di Monastero Bormida - da lui definito "una
terricciuola tra Langhe e Basso Monferrato" - ad altre località
contigue non solo per geografia fisica ma per geografia d'affetto: Ponti,
Monesiglio, Canelli, Acqui, Bistagno... Ma qui, riproponendo in occasione
del trentennio della morte di Augusto Monti un itinerario prettamente astigiano
alla scoperta dei suoi luoghi,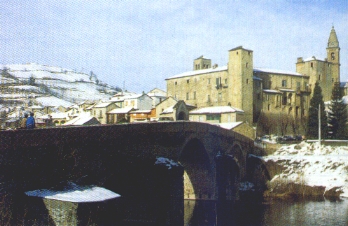 è proprio su Monastero che intendiamo soffermarci: perchè
è un paese straordinario, chiuso come un'urna intorno alla sua monumentalità
medioevale solenne eppure familiare, aristocratica eppure popolare. Vale
la pena di scoprire, dedicandogli una giornata di turismo raffinato e riposante,
un concentrico in cui, all'interno di un poderoso castello quadrangolare
con due torri angolari, originario del XI secolo e rifatto nel XIV, spicca
la gemma di una loggetta rinascimentale; un nucleo storico dove un arco
di rara spettacolarità unisce il campanile romanico dell'XI secolo
al castello ( e non c'è fotografo, dilettante o professionista,
che abbia mancato di immortalarne l'aerea parabola); oppure certi angoli
delle strette strade interne, ingentilite da balconate di gerani, da minuscoli
negozi dal sapore antico e dimenticato. Un paese che punta su di un turismo
non chiassoso ma raffinato, mantenendo fede alle sue tradizioni più
antiche, prima fra tutte il quasi bisecolare polentone, festa d'esordio
di primavera dal sapore propiziatorio, o il canto della quaresima, che
presenta singolari assonanze con analoghe tradizioni provenziali. Il turista
che visita il castello di Monastero Bormida, vetusto maniero d'epoca altomedioevale,
segno visibile della plurisecolare storia del paese, nota una lapide, affissa
alla facciata. Non è una lastra di marmo vistosa: due date, un nome,
una breve dicitura costituiscono il suo unico, schematico contenuto: eppure
questo epitaffio è l'unico segno visibile che Monastero ha dedicato
al suo figlio più illustre, allo scrittore ed educatore ed antifascista
Augusto Monti, vanto della cultura torinese fra le due guerre, maestro
e ispiratore di tanti personaggi di spicco delle letteratura e della politica,
da Pavese a Bobbio, da Mila a Paietta. Uomo di langa fino alla fine, anche
se visse sempre nelle grandi città, Monti, insieme a Fenoglio e
Pavese, lascia a tutti noi un'eredità letteraria e soprattutto morale
forse "scomoda", ma oltremodo rigorosa e nemica di ogni forma di compromesso.
Luigi Gallareto (da "Estate '94 in Valbormida Valbelbo, Langhe e Cebano")
è proprio su Monastero che intendiamo soffermarci: perchè
è un paese straordinario, chiuso come un'urna intorno alla sua monumentalità
medioevale solenne eppure familiare, aristocratica eppure popolare. Vale
la pena di scoprire, dedicandogli una giornata di turismo raffinato e riposante,
un concentrico in cui, all'interno di un poderoso castello quadrangolare
con due torri angolari, originario del XI secolo e rifatto nel XIV, spicca
la gemma di una loggetta rinascimentale; un nucleo storico dove un arco
di rara spettacolarità unisce il campanile romanico dell'XI secolo
al castello ( e non c'è fotografo, dilettante o professionista,
che abbia mancato di immortalarne l'aerea parabola); oppure certi angoli
delle strette strade interne, ingentilite da balconate di gerani, da minuscoli
negozi dal sapore antico e dimenticato. Un paese che punta su di un turismo
non chiassoso ma raffinato, mantenendo fede alle sue tradizioni più
antiche, prima fra tutte il quasi bisecolare polentone, festa d'esordio
di primavera dal sapore propiziatorio, o il canto della quaresima, che
presenta singolari assonanze con analoghe tradizioni provenziali. Il turista
che visita il castello di Monastero Bormida, vetusto maniero d'epoca altomedioevale,
segno visibile della plurisecolare storia del paese, nota una lapide, affissa
alla facciata. Non è una lastra di marmo vistosa: due date, un nome,
una breve dicitura costituiscono il suo unico, schematico contenuto: eppure
questo epitaffio è l'unico segno visibile che Monastero ha dedicato
al suo figlio più illustre, allo scrittore ed educatore ed antifascista
Augusto Monti, vanto della cultura torinese fra le due guerre, maestro
e ispiratore di tanti personaggi di spicco delle letteratura e della politica,
da Pavese a Bobbio, da Mila a Paietta. Uomo di langa fino alla fine, anche
se visse sempre nelle grandi città, Monti, insieme a Fenoglio e
Pavese, lascia a tutti noi un'eredità letteraria e soprattutto morale
forse "scomoda", ma oltremodo rigorosa e nemica di ogni forma di compromesso.
Luigi Gallareto (da "Estate '94 in Valbormida Valbelbo, Langhe e Cebano")
ARABA
FENICE EDIZIONI
Il
"professore" per antonomasia nasce a Monastero Bormida (allora in provincia
di Cuneo , oggi ad Asti ) , terra di langa al confine con l' Appennino
ligure ed il Monferrato, nel 1881. Due anni dopo, in seguito alla morte
della madre e a causa delle precarie condizioni economiche, tutta la famiglia
si trasferisce a Torino, dove il padre aveva già vissuto in giovinezza.
Nel 1904, compiuti gli studi classici, Augusto Monti si laurea in lettere
e dopo una breve esperienza nell'istituto tecnico "Pacchiotti" di Giaveno,
comincia ad insegnare nei ginnasi e nei licei di tutta Italia : Bosa, Chieri,
Reggio Calabria, Sondrio. Profondamente impegnato nella battaglia per il
rinnovamento della società italiana, incontra personaggi quali Giustino
Fortunato, Gaetano Salvemini, Giuseppe Lombardo Radice e collabora alle
riviste più importanti dell'epoca( "La voce", " Nuovi doveri", "Unità")
scrivendo articoli di argomento didattico educativo. Con la coerenza che
fin dall' inizio ne contraddistingue la personalità, partecipa volontario
alla Grande Guerra; fatto prigioniero dagli Austriaci, trascorre due anni
nei campi di Mauthausen e di Theresienstadt. Alla fine del conflitto, torna  immediatamente
in cattedra e nel gennaio del 1919 ottiene il trasferimento a Brescia.
Giunge infine a Torino nel 1924, professore di italiano e latino presso
il liceo classico Massimo D'Azeglio, dove insegnano tra gli altri Umberto
Cosmo e Zino Zini; qui , fino alla metà degli anni trenta diventa
il maestro di una straordinaria generazione di allievi quali Cesare Pavese,
Massimo Mila, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Salvatore Luria, Giancarlo
Pajetta, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Tullio Pinelli. In questo periodo
stringe un'intensa amicizia con Piero Gobetti ( "l'allievo che si fa maestro..."),
che nel 1923 gli pubblica il primo libro, "Scuola classica e vita moderna";
nel frattempo, inizia a collaborare a "Rivoluzione liberale", al "Corriere
della sera" ed al "Baretti", collaborazioni che cessano una dopo l'altra
con l'avvento del fascismo. Nel tempo libero che gli lascia la scuola scrive
intanto il suo capolavoro, "La storia di papà", saga familiare e
dell'Italia Risorgimentale, che dopo una prima edizione uscita in tre parti
dall'editore milanese Ceschina tra il 1928 e il 1935, sarà pubblicata
da Einaudi nel 1947 con il titolo "Tradimento e fedeltà", per diventare
poi definitivamente quindici anni più tardi "I Sanssossi" (Gli Spensierati).
Intanto, nel 1936, viene arrestato e condannato dal Tribunale Speciale
a cinque anni di carcere; rifiutatosi di firmare la domanda di grazia che
gli avrebbe valso l'immediata scarcerazione, trascorre tre anni nei penitenziari
di " Regina Coeli" e Civitavecchia. Nel 1939, in seguito all'amnistia generale,
viene liberato e torna a Torino; qualche tempo dopo, però è
costretto a lasciare la città ed a rifugiarsi in campagna a causa
delle perquisizioni intimidatorie cui viene sottoposto in più occasioni.
Nel secondo dopoguerra si dedica a tempo pieno all'attività di scrittore
e opinionista, collaborando alle pagine torinesi del quotidiano "L'Unità".
Pubblica ancora due romanzi, "Ragazza 1924"e "Vietato pentirsi", e la sua
autobiografia di professore , "I miei conti con la scuola", che in forma
di bilancio traccia il quadro di un secolo di scuola italiana. Muore, ottantacinquenne,
a Roma nel 1966. immediatamente
in cattedra e nel gennaio del 1919 ottiene il trasferimento a Brescia.
Giunge infine a Torino nel 1924, professore di italiano e latino presso
il liceo classico Massimo D'Azeglio, dove insegnano tra gli altri Umberto
Cosmo e Zino Zini; qui , fino alla metà degli anni trenta diventa
il maestro di una straordinaria generazione di allievi quali Cesare Pavese,
Massimo Mila, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Salvatore Luria, Giancarlo
Pajetta, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Tullio Pinelli. In questo periodo
stringe un'intensa amicizia con Piero Gobetti ( "l'allievo che si fa maestro..."),
che nel 1923 gli pubblica il primo libro, "Scuola classica e vita moderna";
nel frattempo, inizia a collaborare a "Rivoluzione liberale", al "Corriere
della sera" ed al "Baretti", collaborazioni che cessano una dopo l'altra
con l'avvento del fascismo. Nel tempo libero che gli lascia la scuola scrive
intanto il suo capolavoro, "La storia di papà", saga familiare e
dell'Italia Risorgimentale, che dopo una prima edizione uscita in tre parti
dall'editore milanese Ceschina tra il 1928 e il 1935, sarà pubblicata
da Einaudi nel 1947 con il titolo "Tradimento e fedeltà", per diventare
poi definitivamente quindici anni più tardi "I Sanssossi" (Gli Spensierati).
Intanto, nel 1936, viene arrestato e condannato dal Tribunale Speciale
a cinque anni di carcere; rifiutatosi di firmare la domanda di grazia che
gli avrebbe valso l'immediata scarcerazione, trascorre tre anni nei penitenziari
di " Regina Coeli" e Civitavecchia. Nel 1939, in seguito all'amnistia generale,
viene liberato e torna a Torino; qualche tempo dopo, però è
costretto a lasciare la città ed a rifugiarsi in campagna a causa
delle perquisizioni intimidatorie cui viene sottoposto in più occasioni.
Nel secondo dopoguerra si dedica a tempo pieno all'attività di scrittore
e opinionista, collaborando alle pagine torinesi del quotidiano "L'Unità".
Pubblica ancora due romanzi, "Ragazza 1924"e "Vietato pentirsi", e la sua
autobiografia di professore , "I miei conti con la scuola", che in forma
di bilancio traccia il quadro di un secolo di scuola italiana. Muore, ottantacinquenne,
a Roma nel 1966.
A trent'anni
dalla scomparsa , è stato indetto un premio recante il suo nome,
il "Premio Augusto Monti- Per amore di un libro", e non si tratta del solito
premio letterario , ma bensì di qualcosa di veramente diverso, perfettamente
in linea con la figura del "professore". Infatti, il concorso non è
stato ideato per scoprire nuovi scrittori , ma piuttosto per premiare la
lettura, ed in particolare i giovani lettori: per potervi partecipare,
occorre avere tra i 15 ed i 21 anni di età, e si deve inviare uno
scritto riguardante il proprio libro preferito. Il premio ha respiro nazionale
ed ha avuto, per la sua prima edizione (che avrà il suo culmine
al Salone del Libro di Torino, il 18 maggio), un grande successo di partecipazione,
nonchè di stima presso gli operatori del settore, dalla scuola alla
libreria.
Inoltre,
sempre per l'anniversario, son previsti durante tutto il 1996 incontri,
dibattiti, manifestazioni e percorsi letterari-paesaggistici nei luoghi
de "I Sansossì".
Foto
di: Giulio Morra.
|
 immediatamente
in cattedra e nel gennaio del 1919 ottiene il trasferimento a Brescia.
Giunge infine a Torino nel 1924, professore di italiano e latino presso
il liceo classico Massimo D'Azeglio, dove insegnano tra gli altri Umberto
Cosmo e Zino Zini; qui , fino alla metà degli anni trenta diventa
il maestro di una straordinaria generazione di allievi quali Cesare Pavese,
Massimo Mila, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Salvatore Luria, Giancarlo
Pajetta, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Tullio Pinelli. In questo periodo
stringe un'intensa amicizia con Piero Gobetti ( "l'allievo che si fa maestro..."),
che nel 1923 gli pubblica il primo libro, "Scuola classica e vita moderna";
nel frattempo, inizia a collaborare a "Rivoluzione liberale", al "Corriere
della sera" ed al "Baretti", collaborazioni che cessano una dopo l'altra
con l'avvento del fascismo. Nel tempo libero che gli lascia la scuola scrive
intanto il suo capolavoro, "La storia di papà", saga familiare e
dell'Italia Risorgimentale, che dopo una prima edizione uscita in tre parti
dall'editore milanese Ceschina tra il 1928 e il 1935, sarà pubblicata
da Einaudi nel 1947 con il titolo "Tradimento e fedeltà", per diventare
poi definitivamente quindici anni più tardi "I Sanssossi" (Gli Spensierati).
Intanto, nel 1936, viene arrestato e condannato dal Tribunale Speciale
a cinque anni di carcere; rifiutatosi di firmare la domanda di grazia che
gli avrebbe valso l'immediata scarcerazione, trascorre tre anni nei penitenziari
di " Regina Coeli" e Civitavecchia. Nel 1939, in seguito all'amnistia generale,
viene liberato e torna a Torino; qualche tempo dopo, però è
costretto a lasciare la città ed a rifugiarsi in campagna a causa
delle perquisizioni intimidatorie cui viene sottoposto in più occasioni.
Nel secondo dopoguerra si dedica a tempo pieno all'attività di scrittore
e opinionista, collaborando alle pagine torinesi del quotidiano "L'Unità".
Pubblica ancora due romanzi, "Ragazza 1924"e "Vietato pentirsi", e la sua
autobiografia di professore , "I miei conti con la scuola", che in forma
di bilancio traccia il quadro di un secolo di scuola italiana. Muore, ottantacinquenne,
a Roma nel 1966.
immediatamente
in cattedra e nel gennaio del 1919 ottiene il trasferimento a Brescia.
Giunge infine a Torino nel 1924, professore di italiano e latino presso
il liceo classico Massimo D'Azeglio, dove insegnano tra gli altri Umberto
Cosmo e Zino Zini; qui , fino alla metà degli anni trenta diventa
il maestro di una straordinaria generazione di allievi quali Cesare Pavese,
Massimo Mila, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Salvatore Luria, Giancarlo
Pajetta, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Tullio Pinelli. In questo periodo
stringe un'intensa amicizia con Piero Gobetti ( "l'allievo che si fa maestro..."),
che nel 1923 gli pubblica il primo libro, "Scuola classica e vita moderna";
nel frattempo, inizia a collaborare a "Rivoluzione liberale", al "Corriere
della sera" ed al "Baretti", collaborazioni che cessano una dopo l'altra
con l'avvento del fascismo. Nel tempo libero che gli lascia la scuola scrive
intanto il suo capolavoro, "La storia di papà", saga familiare e
dell'Italia Risorgimentale, che dopo una prima edizione uscita in tre parti
dall'editore milanese Ceschina tra il 1928 e il 1935, sarà pubblicata
da Einaudi nel 1947 con il titolo "Tradimento e fedeltà", per diventare
poi definitivamente quindici anni più tardi "I Sanssossi" (Gli Spensierati).
Intanto, nel 1936, viene arrestato e condannato dal Tribunale Speciale
a cinque anni di carcere; rifiutatosi di firmare la domanda di grazia che
gli avrebbe valso l'immediata scarcerazione, trascorre tre anni nei penitenziari
di " Regina Coeli" e Civitavecchia. Nel 1939, in seguito all'amnistia generale,
viene liberato e torna a Torino; qualche tempo dopo, però è
costretto a lasciare la città ed a rifugiarsi in campagna a causa
delle perquisizioni intimidatorie cui viene sottoposto in più occasioni.
Nel secondo dopoguerra si dedica a tempo pieno all'attività di scrittore
e opinionista, collaborando alle pagine torinesi del quotidiano "L'Unità".
Pubblica ancora due romanzi, "Ragazza 1924"e "Vietato pentirsi", e la sua
autobiografia di professore , "I miei conti con la scuola", che in forma
di bilancio traccia il quadro di un secolo di scuola italiana. Muore, ottantacinquenne,
a Roma nel 1966.
 quell'acqua
- sorgive, acquitrini, ruscelli, fili d'argento tra i sassi e il verde
- lemme lemme se ne cola laggiù, rinfresca, irriga, abbevera, fa
muovere le ruote dei mulini, ed è una bellezza, ed è una
benedizione. Ma quando al padreterno lassù gli gira la testa e su
quel cielo da tutte le parti nuvole richiama, nuvole brutte verdi e pregne
di minacce, e poi, d'una saettata in mezzo a quell'apocalisse, schianta
squarcia via tutto, e dallo sdruscio acqua grandine manda, giù a
scatarosci: allora fontane rigurgitano, fossi corrono colmi, rivi traboccano,
torrenti rapiscono ruinano, e tutta quell'iradiddio purtroppo va a finire
laggiù. E ne san qualcosa tutti quei borghi posti su quel fiume:
e qualcosa ne sa Cortemilia, specie Borgo San Michele, la covata di case
in riva al Bormida. Anzi Cortemilia allora, adesso forte non più,
aveva perciò una specialità, oltre a quella delle robiole:
un ponte il quale era costruito in modo così ingegnoso che sempre,
alla piena, tavole travi tronchi sterpi fasciname rapiti dall'onda s'impigliavano
tra quelle pile e lì, si capisce, facevan presto a fare diga; ma
il ponte di Cortemilia, come si sapeva, era debole delle ginocchia davanti
e per un po', come poteva, reggeva, reggeva, ma poi, di schianto, ad ogni
piena, puntualmente, si lasciava andare, e lì si sapeva quel che
succedeva: le vie basse di Cortemilia, è vero, si svuotavano in
un attimo, ma in compenso l'alluvione si rovesciava sui paesi di sotto,
Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero, ecc., dove allora, allez,
venisse un accidente a Cortemilia e al suo ponte, per quei Noè di
sotto era peggio del diluvio universale" Così scriveva Augusto Monti,
ne "I Sansossi'" a proposito dell'inondazione del 1948.
quell'acqua
- sorgive, acquitrini, ruscelli, fili d'argento tra i sassi e il verde
- lemme lemme se ne cola laggiù, rinfresca, irriga, abbevera, fa
muovere le ruote dei mulini, ed è una bellezza, ed è una
benedizione. Ma quando al padreterno lassù gli gira la testa e su
quel cielo da tutte le parti nuvole richiama, nuvole brutte verdi e pregne
di minacce, e poi, d'una saettata in mezzo a quell'apocalisse, schianta
squarcia via tutto, e dallo sdruscio acqua grandine manda, giù a
scatarosci: allora fontane rigurgitano, fossi corrono colmi, rivi traboccano,
torrenti rapiscono ruinano, e tutta quell'iradiddio purtroppo va a finire
laggiù. E ne san qualcosa tutti quei borghi posti su quel fiume:
e qualcosa ne sa Cortemilia, specie Borgo San Michele, la covata di case
in riva al Bormida. Anzi Cortemilia allora, adesso forte non più,
aveva perciò una specialità, oltre a quella delle robiole:
un ponte il quale era costruito in modo così ingegnoso che sempre,
alla piena, tavole travi tronchi sterpi fasciname rapiti dall'onda s'impigliavano
tra quelle pile e lì, si capisce, facevan presto a fare diga; ma
il ponte di Cortemilia, come si sapeva, era debole delle ginocchia davanti
e per un po', come poteva, reggeva, reggeva, ma poi, di schianto, ad ogni
piena, puntualmente, si lasciava andare, e lì si sapeva quel che
succedeva: le vie basse di Cortemilia, è vero, si svuotavano in
un attimo, ma in compenso l'alluvione si rovesciava sui paesi di sotto,
Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero, ecc., dove allora, allez,
venisse un accidente a Cortemilia e al suo ponte, per quei Noè di
sotto era peggio del diluvio universale" Così scriveva Augusto Monti,
ne "I Sansossi'" a proposito dell'inondazione del 1948. Così, senza che una virgola possa essere cambiata, regge il testo
montiano a drammatica didascalia della disastrosa alluvione del novembre
1994. E, a farne le spese più pesanti, in tutti i luoghi dal Monti
sopra citati, è stato proprio il ponte romanico di Monastero Bormida,
l'elegantissima struttura la cui architettura è stata stravolta
dalla piena del "torrentaccio": divelte le spallette, lesionate le maestose
arcate, sradicata la cappella votiva simbolo di una fede popolare tanto
ingenua quanto sentita. Era l'emblema, quel ponte, non solo del paese ma
di un intero territorio, pertanto si può essere certi che la gente
di Monastero, con l'ostinazione caparbia propria di questi luoghi, si opererà
perchè ritorni ad esserlo in tutta la sua bellezza originaria, aiutata
in quest'opera di non piccolo conto da istituzioni, enti e sodalizi che
al simbolo privilegiato di Monastero, sono da sempre affezionati. Ponte
romanico e torrente Bormida: un rapporto di odio e amore complesso perchè,
se è vero che il paese è conosciuto grazie alla splendida
architettura monumentale del concentrico - campanile, castello, chiesa,
piazza e vicoli - di cui il ponte è straordinaria anticipazione,
è altrettanto vero che sul torrente che gli dà il nome, da
un secolo a questa parte, non si può dire che male. E' infatti la
sua acqua avvelenata dalle scorie di aziende chimiche che stanno a monte,
e per questo motivo scorre rossastra in mezzo a quei ghiaioni dove un tempo,
raccontano i più anziani fra gli abitanti, nidificavano gli aironi.
Augusto Monti, in apertura del volume sopra citato, inserisce il nome del
suo paese natale al primo rigo della prima pagina: un tributo d'affetto
che il futuro professore del D'Azeglio di Torino ripeterà in diverse
occasioni, accumunando il nome di Monastero Bormida - da lui definito "una
terricciuola tra Langhe e Basso Monferrato" - ad altre località
contigue non solo per geografia fisica ma per geografia d'affetto: Ponti,
Monesiglio, Canelli, Acqui, Bistagno... Ma qui, riproponendo in occasione
del trentennio della morte di Augusto Monti un itinerario prettamente astigiano
alla scoperta dei suoi luoghi,
Così, senza che una virgola possa essere cambiata, regge il testo
montiano a drammatica didascalia della disastrosa alluvione del novembre
1994. E, a farne le spese più pesanti, in tutti i luoghi dal Monti
sopra citati, è stato proprio il ponte romanico di Monastero Bormida,
l'elegantissima struttura la cui architettura è stata stravolta
dalla piena del "torrentaccio": divelte le spallette, lesionate le maestose
arcate, sradicata la cappella votiva simbolo di una fede popolare tanto
ingenua quanto sentita. Era l'emblema, quel ponte, non solo del paese ma
di un intero territorio, pertanto si può essere certi che la gente
di Monastero, con l'ostinazione caparbia propria di questi luoghi, si opererà
perchè ritorni ad esserlo in tutta la sua bellezza originaria, aiutata
in quest'opera di non piccolo conto da istituzioni, enti e sodalizi che
al simbolo privilegiato di Monastero, sono da sempre affezionati. Ponte
romanico e torrente Bormida: un rapporto di odio e amore complesso perchè,
se è vero che il paese è conosciuto grazie alla splendida
architettura monumentale del concentrico - campanile, castello, chiesa,
piazza e vicoli - di cui il ponte è straordinaria anticipazione,
è altrettanto vero che sul torrente che gli dà il nome, da
un secolo a questa parte, non si può dire che male. E' infatti la
sua acqua avvelenata dalle scorie di aziende chimiche che stanno a monte,
e per questo motivo scorre rossastra in mezzo a quei ghiaioni dove un tempo,
raccontano i più anziani fra gli abitanti, nidificavano gli aironi.
Augusto Monti, in apertura del volume sopra citato, inserisce il nome del
suo paese natale al primo rigo della prima pagina: un tributo d'affetto
che il futuro professore del D'Azeglio di Torino ripeterà in diverse
occasioni, accumunando il nome di Monastero Bormida - da lui definito "una
terricciuola tra Langhe e Basso Monferrato" - ad altre località
contigue non solo per geografia fisica ma per geografia d'affetto: Ponti,
Monesiglio, Canelli, Acqui, Bistagno... Ma qui, riproponendo in occasione
del trentennio della morte di Augusto Monti un itinerario prettamente astigiano
alla scoperta dei suoi luoghi,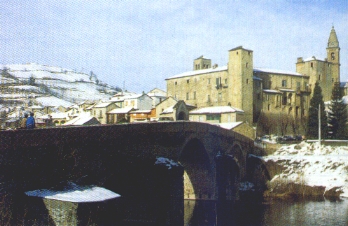 è proprio su Monastero che intendiamo soffermarci: perchè
è un paese straordinario, chiuso come un'urna intorno alla sua monumentalità
medioevale solenne eppure familiare, aristocratica eppure popolare. Vale
la pena di scoprire, dedicandogli una giornata di turismo raffinato e riposante,
un concentrico in cui, all'interno di un poderoso castello quadrangolare
con due torri angolari, originario del XI secolo e rifatto nel XIV, spicca
la gemma di una loggetta rinascimentale; un nucleo storico dove un arco
di rara spettacolarità unisce il campanile romanico dell'XI secolo
al castello ( e non c'è fotografo, dilettante o professionista,
che abbia mancato di immortalarne l'aerea parabola); oppure certi angoli
delle strette strade interne, ingentilite da balconate di gerani, da minuscoli
negozi dal sapore antico e dimenticato. Un paese che punta su di un turismo
non chiassoso ma raffinato, mantenendo fede alle sue tradizioni più
antiche, prima fra tutte il quasi bisecolare polentone, festa d'esordio
di primavera dal sapore propiziatorio, o il canto della quaresima, che
presenta singolari assonanze con analoghe tradizioni provenziali. Il turista
che visita il castello di Monastero Bormida, vetusto maniero d'epoca altomedioevale,
segno visibile della plurisecolare storia del paese, nota una lapide, affissa
alla facciata. Non è una lastra di marmo vistosa: due date, un nome,
una breve dicitura costituiscono il suo unico, schematico contenuto: eppure
questo epitaffio è l'unico segno visibile che Monastero ha dedicato
al suo figlio più illustre, allo scrittore ed educatore ed antifascista
Augusto Monti, vanto della cultura torinese fra le due guerre, maestro
e ispiratore di tanti personaggi di spicco delle letteratura e della politica,
da Pavese a Bobbio, da Mila a Paietta. Uomo di langa fino alla fine, anche
se visse sempre nelle grandi città, Monti, insieme a Fenoglio e
Pavese, lascia a tutti noi un'eredità letteraria e soprattutto morale
forse "scomoda", ma oltremodo rigorosa e nemica di ogni forma di compromesso.
Luigi Gallareto (da "Estate '94 in Valbormida Valbelbo, Langhe e Cebano")
è proprio su Monastero che intendiamo soffermarci: perchè
è un paese straordinario, chiuso come un'urna intorno alla sua monumentalità
medioevale solenne eppure familiare, aristocratica eppure popolare. Vale
la pena di scoprire, dedicandogli una giornata di turismo raffinato e riposante,
un concentrico in cui, all'interno di un poderoso castello quadrangolare
con due torri angolari, originario del XI secolo e rifatto nel XIV, spicca
la gemma di una loggetta rinascimentale; un nucleo storico dove un arco
di rara spettacolarità unisce il campanile romanico dell'XI secolo
al castello ( e non c'è fotografo, dilettante o professionista,
che abbia mancato di immortalarne l'aerea parabola); oppure certi angoli
delle strette strade interne, ingentilite da balconate di gerani, da minuscoli
negozi dal sapore antico e dimenticato. Un paese che punta su di un turismo
non chiassoso ma raffinato, mantenendo fede alle sue tradizioni più
antiche, prima fra tutte il quasi bisecolare polentone, festa d'esordio
di primavera dal sapore propiziatorio, o il canto della quaresima, che
presenta singolari assonanze con analoghe tradizioni provenziali. Il turista
che visita il castello di Monastero Bormida, vetusto maniero d'epoca altomedioevale,
segno visibile della plurisecolare storia del paese, nota una lapide, affissa
alla facciata. Non è una lastra di marmo vistosa: due date, un nome,
una breve dicitura costituiscono il suo unico, schematico contenuto: eppure
questo epitaffio è l'unico segno visibile che Monastero ha dedicato
al suo figlio più illustre, allo scrittore ed educatore ed antifascista
Augusto Monti, vanto della cultura torinese fra le due guerre, maestro
e ispiratore di tanti personaggi di spicco delle letteratura e della politica,
da Pavese a Bobbio, da Mila a Paietta. Uomo di langa fino alla fine, anche
se visse sempre nelle grandi città, Monti, insieme a Fenoglio e
Pavese, lascia a tutti noi un'eredità letteraria e soprattutto morale
forse "scomoda", ma oltremodo rigorosa e nemica di ogni forma di compromesso.
Luigi Gallareto (da "Estate '94 in Valbormida Valbelbo, Langhe e Cebano")