|
|
|
Finalmente il viaggio conduce alla citta' di Tamara.
Ci si addentra per vie fitte di insegne che sporgono dai muri.
L'occhio non vede cose ma figure di cose
che significano altre cose.Se un edificio non porta
nessun insegna o figura,
la sua stessa forma ed il posto che occupa nell'ordine
della citta' bastano a indicarne la funzione.(...)
Fuori si estende la terra vuota fino all'orizzonte, s'apre il cielo
dove corrono le nuvole. Nella forma che il caso e il vento
danno alle nuvole l'uomo e' gia' intento a riconoscere figure:
un veliero, una mano, un elefante...
La citta' e i segni I
|
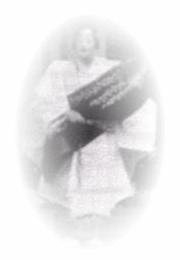
|
Il Noh e' un teatro del soprannaturale, un teatro nel quale gli dei
danzano il fluire del tempo e dello spazio. E' una forma drammatica
esclusivamente giapponese, di tradizione feudale, appartenente agli
ambienti della corte imperiale, conservatosi ritualmente immoto sino
ai nostri giorni. Le fonti sembrano concordare su di una origine
cinese di quella forma di spettacolo di arte varia denominata
sangaku che evolutosi in parte nei numeri del sarugaku sara' poi un
elemento basilare nella costituzione, tra il XIV ed il XV secolo,
del Noh.
Fra VII e X secolo avvengono le prime importazioni in
Giappone del san-yue, danza o musica disordinata, priva di regole,
rurale, non ufficiale, che riuniva in Cina il complesso delle
manifestazioni artistiche assimilate dalle popolazioni
dell'occidente barbaro, e che venivano recitate in contrapposizione
alle danze di corte cinesi. All'origine abbiamo quindi una matrice
arcaica asiatica che giunge in Giappone attraverso la determinante
influenza interpretativa cinese, di carattere prettamente farsesco e
comico: solo in epoca piu' tarda il Noh assumera' il carattere
stilizzante e ritualizzato, imperniato sul racconto del mito che
oggi gli si attribuisce naturalmente. Nel dramma Noh, l'attore
principale e il suo deuteragonista formano una unita'. L'attore
principale e' chiamato shite, l'esecutore, e il secondo attore waki,
ossia spettatore, ospite. Lo shite personifica il dio,ed e' centro
dell'azione drammatica; il waki e' il portavoce del pubblico sul
palcoscenico, il tramite umano che induce il dio a danzare. Non
esiste scenografia, se non il pino sacro dipinto di quinta, e i
movimenti, i gesti e le parole raccontano del tempo del mito e di
uno spazio in cui il divino si manifesta, alla maniera del Jeu
d'Adam e dei
misteri medievali
.
Il mutare dell'azione e del luogo
viene indicato semplicemente dalla posizione e dai movimenti degli
attori.
La recitazione e' fortemente stilizzata: i piedi dello
shite non si alzano mai dal suolo, l'atteggiamento e' di misurata
solennita', che pone in risalto lo status divino del personaggio,in
cui l'irrompere dei sentimenti viene sottolineato dal solo battere
delle calzature del waki contro il pavimento, fortemente risonante,
di legno.
|
Fotografia del fronte palco di un edificio teatrale Noh
e della sua pianta tipo, con la stanza degli specchi a
sinistra e la zona scenica vera e propria in basso a
destra, unite dal ponte.
|

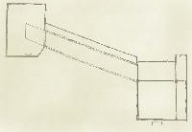
|
Il Noh e' infatti un teatro interamente ligneo, in cipresso
giapponese hinoki, costruito per la gran parte ad incastro. Si
compone di un palco, Noh butai, di un ponte, hashi gakari, di una
stanza di vestizione, detta dello specchio, kagami Noh ma, costruiti
secondo l'arte del kiwari, la proporzione delle parti. Una prima
constatazione evidente e' che lo spazio scenico e' aperto, privo di
sipario, ma coperto di un tetto. Anche oggi, quando il Noh viene
spesso ricostruito all'interno di un altro edificio, il tetto non
viene rimosso; simbolicamente esso indica la santita' dello spazio
sottostante, con espliciti richiami alla tipologia dei santuari
scintoisti e all'ombrello della
cerimonia del te'
, e si estende
oltre il margine del proscenio ad includere la platea. Il palco,
luogo dell'azione scenica, ha come elemento qualificante il pino
dipinto, che conferisce il ma, l'ordine cosmico, al teatro: e'
quello che abbiamo definito l'evento totemico. L'identificazione
tra mito della stabilizzazione come visto in Eliade
e parti della
costruzione teatrale e' totale, a cominciare dall'orientamento a Sud,
in accordanza con il dettato delle quattro divine corrispondenze.
La abbagliante asimmetria dell'insieme palco - ponte - stanza
proviene anch'essa dalla necessita' di concretizzare un modello:
nella tradizione scintoista e buddista esiste l'immagine della terra
pura situata ad occidente, mondo del trascendente.
Il luogo
dell'umano, simbolizzato dal palco, e' teatro di eventi cosmogonici;
l'origine del divino, il momento deificatore, e' la stanza dello
specchio; il tramite e' il ponte, luogo scenico autonomo, leggermente
inclinato verso ovest. La tenda, age maku, che chiude l'entrata
della stanza dello specchio e' realizzata in damasco ricamato in
strisce verticali di cinque colori: da sinistra a destra sono
porpora, bianco, rosso, giallo e verde, e simboleggiano la natura
selvaggia che separa i due piani dell'essere, fuoco acqua terra
vento e aria in accordo con la dottrina dei cinque elementi.
E' interessante notare come i colori rimandino alla disposizione dei
punti cardinali e del centro degli assi, con il colore piu'
importante, il rosso, associato al sud. Cromaticamente non sono
utilizzati colori che rientrano, i colori statici sono posti ai lati
esterni e al centro sono situati i colori che avanzano: l'effetto
che si ottiene e' quello di uns tenda che, vista dalla platea, sporge
in fuori, suggerendo una interessante natura attiva della stanza.
|
La parola astrattismo ha una etimologia affine
al latino ab-trahere
ed allude dunque ad una estrapolazione di forme
dall'immagine riconoscibile del reale.
Con la molto approssimativa formula di "arte astratta"
si cataloga tutta la pittura
che non persegue riscontri riproduttivi del visibile.
F. Caroli, La pittura contemporanea
|
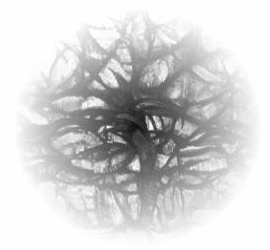
|
Percorsi, danze e cosmogonie
Gli eventi del Noh sono autonomi e complementari nelle loro funzioni
simboliche, ma una gerarchia degli spazi esiste, ed e' invertita
rispetto a queanto il pensiero occidentale si aspetterebbe. Lo
spazio scenico piu' importante e' la stanza dello specchio, il
percorso che abbiamo delineato nei paradigmi indiziari del cerchio
magico e della chiesa romanica viene rovesciato: e' il dio che
cammina verso gli uomini. Kagami Noh ma significa lo spazio del dio.
Lo shite, varcato il velo della natura, percorre poi il ponte,
passando in sequenza il pino che strappa i vestiti, il pino del
vento e il pino delle felicitazioni, mostrando il profilo alla
platea, drammatizzando e accentuando la progressione temporale della
storia. Un effetto utilizzato ad esempio frequentemente nei comics.
La linearita' del cammino e' importante, in quanto in stridente
contrasto con la ciclicita' rotatoria delle danze che avverranno sul
palco, dove, diremmo in sintonia col carattere sacro della
narrazione, il movimento rettilineo e' completamente bandito; shite e
waki svolgono una complessa coreografia che li porta a ruotare,
l'uno in senso antiorario, terrestre, l'altro in senso orario,
celeste, ogni volta che devono fronteggiarsi.
Modello schematico tridimensionale del teatro Noh.
Sono evidenziate le diverse "parti" simboliche che
compongono lo spazio teatrale.
E' evidente la posizione centrale che viene ad assumere
il pino dipinto nella concretizzazione dello spazio/tempo
scenico.
Modello realizzato con Autodesk 3DStudio
|
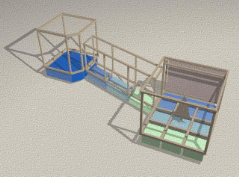
|
Una funzione
particolare svolge anche shirasu, la striscia di ghiaia che contorna
per circa un metro tutto l'edificio teatrale: simbolizza il fluire
delle acque ed enfatizza ulteriormente, isolandolo, l'elemento di
sacralita' del Noh. Il Noh e' luogo sacro, quindi, ed ilsuo spazio
metafisico e' diviso in nove luoghi e tre regioni, che corrispondono
ad eventi nello svolgimento del racconto, e che lo shite raggiunge
nel corso della azione scenica, nel momento prestabilito. E' da
notare come la divisione sia presente non solo nel palco, ma anche
longitudinalmente lungo il ponte: l'unico spazio indifferenziato e'
quello, mitico, del kagami Noh ma. Procendendo dalla age maku verso
la scena abbiamo: jo, la quiete, il momento prefatorio. Sul palco
corrisponde allo jo-za, dove si incomincia a recitare, sul vertice
nord ovest dell'assito in prossimita' del ponte. Segue ha, la
rottura, lo svolgimento: il corrispondente sulla scena e' shonaka,
il centro del palco. Ultimo viene kyu, il culmine, a cui fa eco
sumi, sul limite del proscenio verso la platea. La divisione
spaziale in unita' e' insieme una informazione coreografica e
drammatica sullo svolgersi della vicenda ed una esigenza di tipo
cultuale. Lungo il ponte, la tripartizione serve allo shite per
negare l'esistenza della maschera, muoversi al ritmo della musica,
dirigere la coscienza verso il racconto del mito. Sul palco, lo
schema viene ulteriormente specificato, frattalizzato, nella
partizione in nove quadranti ognuno dei quali ha un nome ed una
funzione propria, e sui quali si proiettano i richiami cromatici e
simbolici della age maku. La alterita' del Noh rispetto alla
tradizione culturale occidentale e' grande, i nostri termini di
paragone si fermano alle rappresentazioni sacre del tardo medioevo
europeo. Il forte aspetto magico e consolatorio, la stordente
ieraticita', sono probabilmente di difficile comprensione fuori dal
Giappone. I temi, i drammi, scritti e mai modificati a cavallo del
XV secolo, mettono in scena, come abbiamo gia' detto, una cosmogonia,
e le affinita' con aspetti rituali della
messa cristiana
e con le
stesse cerimonie shintoiste sono molteplici. Questa suprema
indifferenza verso la il piano della realta', questo ripercorrere
incessantemente i tempi del mito, ha condotto ad introdurre nel
paradigma indiziario procedure inedite per il nostro quadro di
riferimento.Non essendo il gioco dell'asimmetria una caratteristica
peculiare del Noh, gli eventi evolutivi potevano essere ricondotti
alla riduzione alla bidimensionalita' dell'immagine totemica del
pino, alla inversione del rapporto uomo/dio e al conseguente
ribaltamento del percorso iniziatico, all'elemento di ciclicita'
affidato a danze rituali.
Esaminiamo gli eventi di questo nuovo
ciclo. Iconograficamente, il pino dipinto e' una astrazione
paragonabile al percorso che compie Mondrian da Albero argentato del
1911 a Paesaggio con alberi del 1912. La prospettiva e' univoca,
fissa, e' non c'e', in nessuno dei due casi, una reale perdita di
spazialita': e' solo una riduzione ai minimi termini, come a dire
questo e' tutto quello che serve per lo scopo. Il Noh nasce
all'aperto, nelle radure, il pino e' pero' solo segno ormai: sara'
compito del dio ricrearne l'immanenza.
Il senso di passaggio e'
sottolineato, sempre secondo questo percorso inverso che abbiamo
indicato, sia simbolicamente che visivamente in modi diversi. Lo
shite esce da s‚, muove dal centro cosmico nell'occidente, squarcia
il velo della natura e percorre un cammino che lo porta a
manifestare la divinita' e ad imporre nuovamente il tempo e il luogo
del mito, la radura del pino, davanti all'uomo. I movimenti,
abbiamo detto, sono prima rettilinei, poi rotatori.
Ora,
all'interno di questo schema, hashi gakari, il ponte, ha subito una
evoluzione rispetto al dato ricavato dal paradigma indiziario: e'
meno percorso, iniziazione, di quanto sia asse celeste, tramite fra
cielo e terra, una verticale, una scala.
Il procedimento differisce
sensibilmente dall'accesso al sancta cristiano o megalitico, in cui
il dio, per cosi' dire, attende. Nel contempo, verticalizzando,
viene recuperato un elemento gia' presente nei due processi
ricordati. L'elemento ciclico, da noi introdotto come evento nella
lettura ritmica delle pietre di Stonehenge ma avvertibile in decine
di possibili varianti, dalla moltiplicazione frattale del tempio
della Grande Madre a Bali alle proliferazioni di cappelle nelle
chiese cristiane, qui merita una considerazione a parte.
Non vi e'
concretizzazione fisica, nessun cerchio di sassi, allitterazione di
pali, sequenza di nicchie: la ciclicita' si esprime nel movimento
dello shite, che simbolicamente ruota intorno al pino, non davanti.
E' un evento mutevole nel tempo e non identificabile a tratti, una
danza attorno al totem. Complessivamente dal Noh muove una forte
istanza di smaterializzazione degli eventi del sacro: il tempo del
mito e' decisamente presente, ora, ed induce una lettura a ritroso,
rovesciata, delle sequenze eventi/interfaccia individuate dal
paradigma indiziario.
Modello tridimensionale del teatro Noh
|


